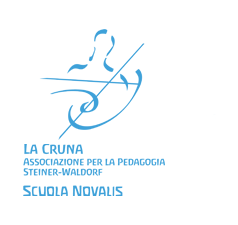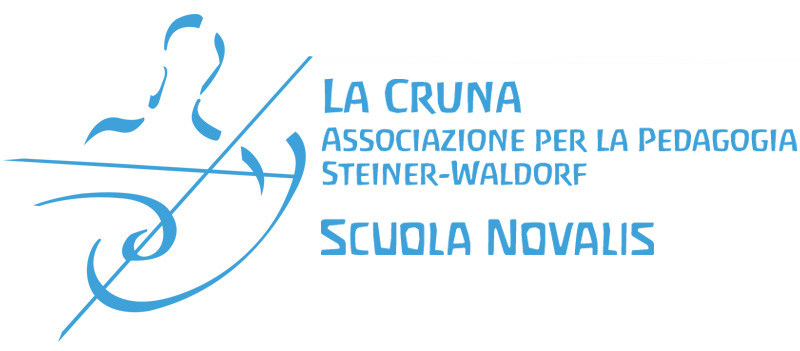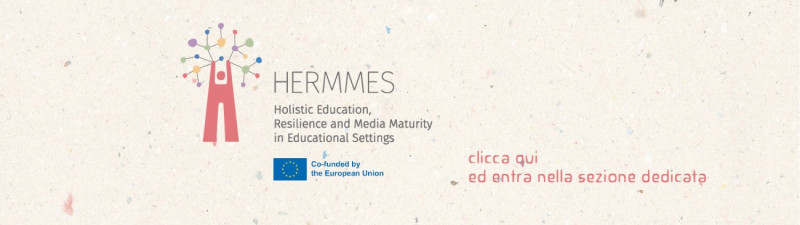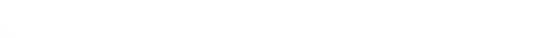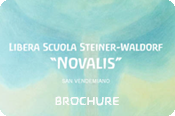News
Il ´Discorso sul metodo´ di Cartesio e i vantaggi di applicarlo nella vita quotidiana
Quest’anno, durante la prima epoca di matematica abbiamo approfondito la geometria analitica e il testo Discorso sul Metodo (1637) di Rene? Descartes, meglio noto in Italia come Cartesio.
Con quest’opera, egli non intende imporre dogmi ai quali tutti debbano attenersi. Vuole piuttosto illustrare un metodo per favorire un pensare che per essere corretto deve procedere lentamente e osservare quattro regole ben definite.
1. Non accettare nulla come vero senza un’evidenza chiara e precisa, evitando precipitazione e pregiudizi;
2. Dividere ogni problema in parti più semplici;
3. Seguire un ordine preciso procedendo dai problemi più semplici ai più complessi,
mantenendo coerenza e rigore;
4. Completare ogni analisi, assicurandosi che nulla sia stato tralasciato, anche attraverso
strumenti come le checklist.
Partendo dalla lettura del testo, l’insegnante ci ha invitati a riflettere su alcuni passi. Alcuni di questi mi hanno particolarmente colpito e provo a sintetizzarli qui.
Per Cartesio, tutti nascono potenzialmente con lo stesso livello di razionalità, ma al contempo con la vocazione a seguire modi completamente differenti di condurre il proprio pensare. Ha frequentato le migliori scuole e avuto accesso a libri autorevoli, ma confessa di non avervi trovato le risposte che cercava. Tuttavia riconosce l’utilità dei suoi studi, perché le arti e le scienze apprese hanno contribuito a formare il suo giudizio.
Deluso dall’incapacità degli studi altrui di fornirgli risposte soddisfacenti, Cartesio inizia a viaggiare.
Esplora diverse culture, osserva i ragionamenti delle persone e si impegna a comprendere i loro pensieri. Scopre cosi? la relatività delle verità, diverse da luogo a luogo, e si rende conto di quanto i pregiudizi influenzino le opinioni personali. Questo lo conduce a intraprendere un viaggio interiore e scopre che le verità più significative risiedono dentro di noi e qui vanno cercate.
Secondo Cartesio e? importante restare collegati al mondo, prestare costante attenzione, evitare di smarrirsi rincorrendo mille teorie. Il grande pensatore considera la matematica una ‘materia robusta’ col rammarico che ‘non abbia dato vita a costruzioni maestose, a differenza delle materie filosofiche per le quali, pur mancanti di solide basi, sono stati edificati magnifici castelli, pur destinati a crollare’. Per Cartesio, la filosofia infatti non arriva a una verità definitiva, e le scienze che traggono da essa i propri principi non avranno mai fondamenta solide. Ritiene inoltre che Dio sia accessibile a tutti, anche agli ignoranti, e che in questa materia la ragione non sia utile perché il divino e? qualcosa che va oltre l’intelletto.
Cartesio ricorre alla potente metafora "un cantiere, un unico architetto" per sottolineare che i lavori portati avanti da un unico progettista risulteranno più belli rispetto a quelli realizzati a più mani. Similmente, anche per la crescita armoniosa di una società, l’autore ritiene sia necessario un unico soggetto a varare le leggi, cosi? da rendere le norme coerenti tra loro.
Anziché lasciarsi trascinare dai propri desideri, Cartesio suggerisce di seguire il principio guida della ragione, e propone un esempio: le case vanno demolite solo quando stanno per crollare e solo dopo vanno ricostruite, su fondamenta più solide. L’analogia riflette il pensiero di Cartesio che non vuole distruggere il mondo: nonostante gli errori del passato, e? comunque importante preservare le vecchie tradizioni per poi costruirci sopra nuove strade. Il cambiamento che si desidera nel mondo, inizia prima di tutto da se stessi.
Cartesio reputa il suo metodo estremamente potente perché lo ha formulato basandosi fin dall’inizio sulla matematica, materia che considera fondamentale per abituare la mente a nutrirsi di verità.
L’autore distingue l’umanità in due grandi gruppi: le persone troppo precipitose che, credendo di sapere tutto, saltano a conclusioni affrettate senza ragionare, e coloro che invece si considerano poco capaci e, comportandosi di conseguenza, rischiano continuamente di perdere opportunità.
Su questo tema l’insegnante ci ha invitato a riflettere. Sentivamo di appartenere al gruppo dei precipitosi o di coloro che si sottostimano? Mi e? sembrato di riconoscermi nel secondo, avendo la tendenza a nutrire dubbi sulle mie capacità. Non credo questo significhi totale assenza di talenti, ma indichi piuttosto una propensione a confrontarmi con gli altri ‘al ribasso’. Ci ha poi chiesto quali fossero le qualità umane necessarie per portare un impulso positivo al mondo. In tal senso, credo sia essenziale coltivare alcune qualità chiave. Come ad esempio l’altruismo che ci spinge a considerare le esigenze altrui prima delle nostre, creando un legame all’insegna di empatia e comprensione. L’integrità morale e? un’altra qualità secondo me importante. Essa implica onestà, capacità di assumersi la responsabilità delle proprie azioni, coerenza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo e ci guida nel prendere decisioni etiche. Essere integri significa avere il coraggio di difendere ciò che e? giusto, anche quando risulta difficile o impopolare. Un altro esempio potrebbe essere la coerenza, essenziale per mantenere una direzione chiara nelle nostre azioni e nelle nostre scelte, rimanendo fedeli ai propri valori anche di fronte alle sfide più ardue. In aggiunta a queste qualità, ritengo sia indispensabile promuovere il dialogo come strumento per migliorare le relazioni tra le persone. Spesso ci troviamo di fronte a opinioni diverse e a volte opposte.
Accogliere l’opinione dell’altro può risultare difficile. Tuttavia, favorire il dialogo aiuta a metterci nei panni altrui e a comprendere le loro esperienze, anche quando non siamo d’accordo con i loro pensieri.
E? altrettanto importante non farsi influenzare eccessivamente dalle convinzioni altrui, ma lavorare sulla propria autostima e sulla capacità di formarsi un’opinione personale, per sviluppare una voce propria nel mondo. Non per questo vanno ignorate le idee degli altri, meglio sarebbe integrarle alle nostre usando un buon senso critico, in modo da accrescere e ampliare i nostri orizzonti. Queste qualità non solo migliorano le nostre vite ma possono anche ispirare e influenzare positivamente gli altri, contribuendo a creare una società più aperta al confronto.
E voi cari lettori, cosa ne pensate?
Lucrezia – XI cl.